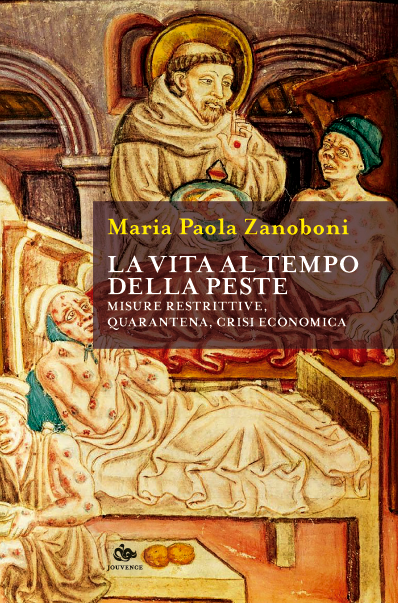
Psicosi collettiva. Caccia ai potenziali untori. Negazione delle prime avvisaglie del contagio per timore degli effetti devastanti sull’economia. Misure restrittive con gravissime conseguenze sul commercio e sull’economia. Assalti ai forni per paura della quarantena. Sussidi per i disoccupati. E governi costretti a sanare il deficit con prestiti, nuove tasse e emissione di titoli del debito pubblico. Le sconcertanti analogie attraverso i secoli di fronte al contagio nell’ultimo libro di libro Maria Paola Zanoboni, “La vita al tempo della peste. Misure restrittive, quarantena, crisi economica”, Jouvence (Mimesis Edizioni).
Dall’antichità ai primi decenni del XVIII secolo le epidemie di peste coinvolsero ovunque tutti i possibili aspetti della vita economica, politica e sociale, con analogie impressionanti comuni a tutte le epoche della storia: dalla psicosi collettiva, alla caccia ai potenziali untori, alla negazione delle prime avvisaglie del contagio per timore degli effetti economici che avrebbero innescato; alle devastanti conseguenze sul commercio e sull’economia (in primis la “crisi del ‘300”), dovute alle misure restrittive; ai tentativi dei governi di sanare il deficit con prestiti, emissione di titoli del debito pubblico, nuove tasse, e di soccorrere con sussidi i disoccupati; agli assalti ai forni per paura della quarantena.

È sconcertante come, nonostante i progressi nelle discipline mediche, gli strumenti di prevenzione disponibili ai nostri giorni siano gli stessi elaborati nel ‘300, a partire dal Nord della Penisola (Gian Galeazzo Visconti ne fu uno dei principali ideatori), recepiti tardi dal resto dell’Europa (tardissimo dal’Inghilterra, che li mise in pratica solo alla fine del ‘500, su consiglio dei medici padovani presenti a Londra), e adottati con successo fino al 1720, quando l’ultimo cordone sanitario (a Marsiglia) debellò quasi del tutto il morbo dal Vecchio Continente.
Il ricorso a forme di vera e propria “dittatura sanitaria” fu dal ‘300 al ‘700 il metodo comunemente adottato per cercare di far rispettare le misure restrittive.
Divieto di accesso e di uscita dalle città colpite, stretta sorveglianza sui movimenti di merci e persone, cordoni sanitari, isolamento, quarantena e “quarantena generale” (ovvero lockdown con modalità identiche a quelle attuali); divieto di assembramento e di ritrovo, chiusura di attività commerciali, taverne, scuole, luoghi di pubblico intrattenimento; cancellazione delle manifestazioni di ogni tipo, comprese le fiere e i mercati; divieto di partecipare a cerimonie religiose, processioni, funerali; “bollette e fedi di sanità” (passaporti che consentivano la circolazione di persone e merci attestando la provenienza da luoghi non contagiati): questi i provvedimenti sanitari messi in atto a partire dalla metà del ‘300 per prevenire e limitare il contagio.
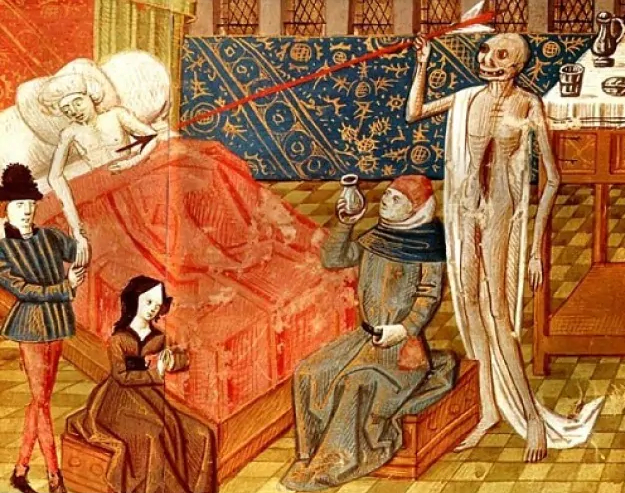
Tra queste disposizioni veniva comunemente adottata, soprattutto a partire dal ‘500, la quarantena generale, ovvero la reclusione in casa di tutta la popolazione per un dato periodo di tempo. I reclusi erano rifocillati a spese dello stato se indigenti, oppure veniva concesso solo al capofamiglia di uscire di casa, la mattina, per procurarsi i viveri.
La gente mal sopportava tale situazione, e cercava con ogni sotterfugio di continuare i propri commerci, come descrivono ampiamente i carteggi delle magistrature sanitarie.
La popolazione dell’entroterra ligure , sprezzante dei divieti, continuava tranquillamente i propri traffici lungo il crinale dell’Appennino. I fiorentini erano refrattari ad ogni costrizione e durante l’epidemia del 1630, anziché rispettare l’obbligo dell’isolamento imposto dalla quarantena generale, andavano ugualmente al lavoro, e se rimanevano a casa (perché guadagnavano meno del sussidio statale di cui potevano usufruire), invece di osservare l’obbligo dell’isolamento, “vanno attorno, conversano, sono raccettati da altri, introducono nelle case loro altre genti”. E lo stesso accadeva nelle altre località della Toscana, a Napoli, a Milano, a Palermo.
Esistevano poi precise norme di quarantena per le merci, e regole scrupolose di sanificazione delle case e delle suppellettili (alla cui distruzione col fuoco i più poveri si opponevano strenuamente). Per le masserizie comuni (materassi di lana e piuma) si utilizzava la ripetuta bollitura nell’aceto (lana e tessuti), mentre le piume venivano spruzzate una per una con l’aceto bollente, che avendo la capacità di tenere lontani gli insetti (e quindi le pulci vettore della peste bubbonica), veniva comunemente utilizzato come disinfettante.
San Carlo lo usava per sanificare le monete che dava agli appestati e per lavarsi le mani prima e dopo aver somministrato loro la comunione. I tessuti preziosi venivano lasciati all’aria e disinfettati con fumi di incenso, mirra, laudano.
Interi settori dei lazzaretti di molte città di mare (Ragusa Dubrovnik, Venezia, Genova) erano adibiti alla quarantena delle merci provenienti dai paesi sospetti, e in particolare da quelli musulmani, dove la peste era endemica e non venivano presi adeguati provvedimenti. Il fatalismo delle popolazioni musulmane troncava infatti sul nascere ogni tentativo di prevenzione.

Ma tutto questo rallentava paurosamente i traffici aumentandone i costi, per cui i tentativi di aggirare le le pratiche di quarantena erano continui.
La necessità di regolamentare e far rispettare le misure preventive contro il contagio portò in Italia (e solo in un secondo tempo in Europa) alla creazione di magistrature sanitarie permanenti dotate di amplissimi poteri, fino a diventare, nei momenti di emergenza, vere e proprie forme di dittatura sanitaria.
La principale venne instaurata a Palermo nel 1575 dal medico e deputato alla sanità Giovanni Filippo Ingrassia, che non esitò a disseminare di forche le vie cittadine per convincere la gente ad obbedire. I suoi metodi, basati sulla triade “oro” (cioè denaro necessario alle spese per l’emergenza), “fuoco” (per bruciare le suppellettili infette), “forca” (per punire i trasgressori), furono imitate ed applicate assiduamente in tutta la Penisola. Persino i Cappuccini incaricati nel 1576 e nel 1630 di gestire il Lazzaretto di Milano non ebbero scrupoli ad adottare tali metodi.
Misure molto severe vennero prese anche a Genova (dove la popolazione era particolarmente indisciplinata e refrattaria a interrompere i propri commerci) in occasione delle epidemie cinquecentesche e seicentesche. A Venezia nel 1504 il Senato attribuì ai Provveditori di Sanità la facoltà di arrestare gli inquisiti e di sottoporli a tortura.
A Corfù nel ‘600 i Provveditori di Sanità erano dotati di amplissimi poteri giurisdizionali: potevano ordinare il rogo delle merci e delle navi infette e condannare a morte chiunque fosse stato sospettato di aver diffuso, anche in modo involontario, la peste. Ovunque si minacciava di giustiziare davanti alla porta di casa chi non rispettava la quarantena.
Dalla peste dunque arrivò la nascita della sanità pubblica sia a livello di strumenti di controllo del territorio e della popolazione, sia a livello nosocomiale: i lazzaretti infatti, in quanto atti a gestire l’emergenza di una patologia a rapida evoluzione, erano molto più vicini al concetto moderno di ospedale di quanto lo fossero gli “hospitalia” medievali (strutture di ricovero per i viandanti), o i lebbrosari (strutture di lunga degenza).
Le epidemie di peste portarono ovunque e in ogni epoca, in Italia e in Europa, crisi economiche notevolissime, dovute sia alle misure di contenimento degli spostamenti di uomini e merci, che danneggiavano contemporaneamente il commercio e le casse statali (per il mancato introito dei dazi), sia, per le pandemie più gravi, ai mutamenti profondi sull’assetto economico e sociale prodotto quando il crollo demografico era particolarmente repentino e devastante.
L’esempio più grave di crisi economica a livello europeo fu quello provocato dalla pandemia del 1348 e degli anni successivi (la “crisi del ‘300”), che distruggendo 1/3 della popolazione europea (circa 30 milioni di individui su un totale di 100 milioni), ebbe conseguenze epocali in ogni settore dell’economia.
Di fronte alla crisi economica aggravata dalle misure restrittive, la gente preferendo “morire di peste che di fame”, chiedeva a gran voce la “restituzione del commercio”, che i governi cittadini concedevano con molta cautela, trascorso un notevole lasso di tempo dalla fine del contagio. Quando scoppiava un’epidemia di peste, infatti, il sistema degli Uffici di Sanità di tutto il nord della Penisola faceva immediatamente scattare l’allarme, provvedendo a mettere in quarantena la città o il villaggio colpito e causando l’interruzione di ogni rapporto di comunicazione e di scambio.
L’area interessata veniva così a trovarsi nel più completo isolamento, con il conseguente arresto dei traffici e il collasso totale di ogni attività commerciale e manifatturiera. Un rallentamento di tutte le attività vitali si impossessava delle città all’arrivo della pestilenza.

Ovunque gli effetti sull’economia e sull’occupazione erano devastanti: nel 1575 la produzione tessile di Verona venne messa in ginocchio dalla quarantena seguita allo scoppio dell’epidemia, al punto che molti disoccupati erano morti di fame, senza alcun aiuto perché imprigionati in una città completamente isolata.
Nel 1576 a Milano la chiusura di tutte le botteghe e la cessazione di ogni attività economica lasciò senza lavoro e senza sostentamento 80.000 persone.
A Firenze nel 1630 le transazioni commerciali si ridussero del 96%. Quando la medesima epidemia raggiunse Busto Arsizio, la produzione locale di tessuti di cotone venne bandita da tutte le altre località della Penisola, e lo stesso si verificò per i tessuti serici di Genova, colpita nel 1657 dal contagio.
La quarantena di 57 giorni subita da Recco in quell’occasione aveva ridotto la località in ginocchio, mentre i tessitori di seta di Chiavari e Lavagna erano alla fame non potendo esercitare la loro attività per mancanza della materia prima e l’impossibilità di ottenere nuove commissioni.
A Chiavari in particolare mancavano il sale e la farina per fare il pane, e il poco che si riusciva a produrre era “più proporzionato alla distrutione della vita humana che alla sua conservazione”.
A Napoli nel 1656, nonostante il pericolo, moltissimi ambivano diventare inservienti del lazzaretto perché “preferivano morire di peste che di fame”: cessata infatti la produzione della seta e fuggita la nobiltà che dava da vivere agli artigiani, ben 50.000 persone erano ridotte in miseria. Nella città dove “le ville, i giardini, i lidi un tempo ameni e le fresche sponde del mare, spiravano ormai aure pestifere”, non c’era vicolo in cui non si udisse un morto o un moribondo, e innumerevoli vedove, e orfani sopravvivevano solo al dolore, “e quella vita che hanno non so come negata alla peste, si è forza cederla volontariamente alla fame”.
Per rimpinguare i bilanci devastati dalle spese per l’emergenza sanitaria, i metodi dei governi, dal Trecento in poi, furono sempre gli stessi: imposte indirette, contribuzioni straordinarie, prestiti forzosi, emissione di titoli del debito pubblico, nuove tasse.
Maria Paola Zanoboni
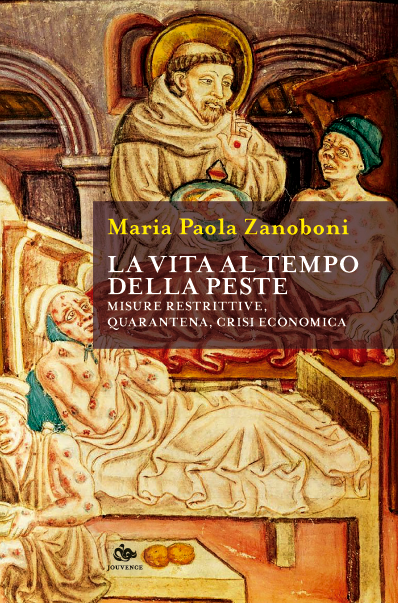
Maria Paola Zanoboni
La vita al tempo della peste
Misure restrittive, quarantena, crisi economica
Milano, Jouvence (Mimesis Edizioni), 2020
Per maggiori informazioni: scheda libro
